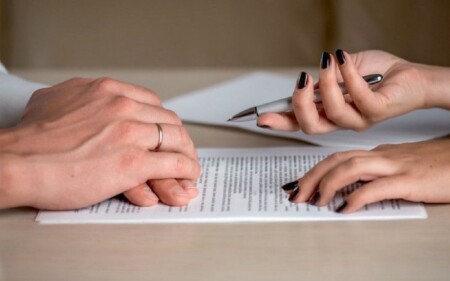Cassazione civile, sez. tributaria, 7 novembre 2023, n. 30983
La clausola penale inserita nel contratto di locazione per il caso di ritardo nella restituzione dell’immobile non è soggetta ad autonoma imposta di registro
La previsione di una clausola penale all’interno di un contratto – nella fattispecie un contratto di locazione – può ritenersi per intrinseca natura connessa al contratto, e quindi, stando al secondo domma dell’art. 21 del D.P.R. 131/1986, sfuggire ad autonoma tassazione applicandosi una sola volta l’imposta come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa?
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la sua necessaria accessorietà (ex multis: Cass., sez. III civ., 26 settembre 2006, n. 18779: “Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato dall’obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest’ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo”. Recentemente le S.U. n. 9775/2022 hanno chiarito che la clausola penale svolge “la funzione civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento”.
La clausola penale - pur nella complessità delle forme del suo manifestarsi - svolge una funzione, non tanto sanzionatorio-punitiva, quanto appunto di risarcimento forfettario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto (da ultimo Cass. 26 luglio 2021, n. 21398; Cass. del 20.01.2023, n. 11548, in motiv.).
La clausola penale ha, allora, secondo la previsione codicistica, lo scopo di sostenere l’esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede. Essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta; dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall’inadempimento dell’obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall’obbligazione contrattuale.
Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell’oggetto del contratto (v. Cass. dell’08/10/2020, n. 21713, in motiv.), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono dunque, per loro inscindibile funzione ed “intrinseca natura” (ed in ciò palesano la loro essenza, appunto, di “clausole” regolamentari di una prestazione più che di “disposizioni” negoziali) all’unitaria disciplina del contratto al quale accedono; venendo per il resto a prestabilire e specificare una prestazione ovvero un obbligo, quello risarcitorio, altrimenti regolato direttamente dalla legge. Tali prestazioni sono, pertanto, riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato da un’unica causa, atteso che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del disciplinare di contratto, di talché non potrebbe affermarsi che le disposizioni - contratto e connessa clausola penale - siano rette da cause diverse e separabili; quindi con l’effetto di doverle considerare derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (in senso conforme Cass. del 13/11/1996, n. 9938).
Ciò conferma che la funzione della clausola penale - desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c. - non può ritenersi eterogenea rispetto all’obbligazione nascente dal contratto di locazione a cui accede, perché sul piano giuridico, l’obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene sia si attivi conseguentemente all’inadempimento dell’obbligazione, non si pone come causa diversa dall’obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all’adempimento sua propria, dunque finalizzata a disincentivare e “riparare” l’inadempimento, oltre che introdotta dal legislatore come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempienza, tutelando anche in ciò, ab initio, la parte adempiente.
È dunque la stessa disposizione di legge che correla gli effetti della clausola penale all’inadempimento contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma - come confermato da Cass. del 26.09.2005, n. 18779 - rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale.
Obbligazione principale che difatti, se per qualsiasi ragione (diversa dall’inadempimento) travolta, non può che rendere per ciò solo al pari inoperante la penale; il che equivale ad osservare che se certo può sussistere, com’è ovvio, un contratto senza penale (tranne che nei casi in cui questa sia imposta direttamente dalla legge, come in materia di appalti pubblici), non può al contrario sussistere quest’ultima senza il contratto, di cui segue per intero le sorti, anche nel caso di sua invalidazione o cessione.
In definitiva la sezione tributaria della Suprema corte ha affermato il principio di dirietto per cui, aai fini dell’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal comma 2 del summenzionato articolo.
D.P.R. 131/1986
Articolo 21 - Atti che contengono più disposizioni.
1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. tributaria, 7 novembre 2023, n. 30983