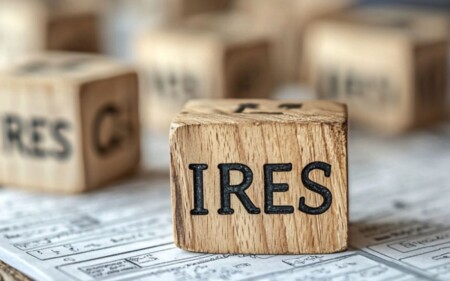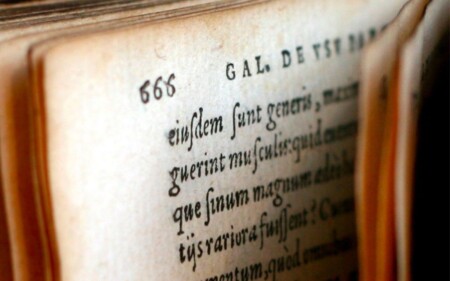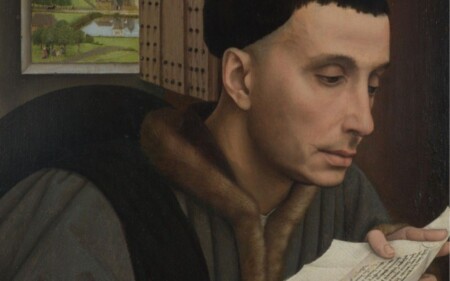Cassazione penale, sez. IV, 15 settembre 2020, n. 27234
Redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio: non vanno computate le somme percepite a titolo di risarcimento danno, salvo che si tratti di risarcimento per mancata percezione redditi.
Ai fini dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato le somme percepite a titolo di risarcimento del danno diverso dalla perdita di redditi non rilevano nella determinazione del reddito complessivo rilevante per l’ammissione al beneficio.
Nella fattispecie l’istante non aveva dichiarato la rendita percepita da parte dell’Inail quale indennizzo per la morte di un figlio ed era finito imputato del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale, dichiarato falsamente il reddito complessivo del nucleo familiare,
Secondo la Suprema Corte ai fini dell’ammissione al cosiddetto gratuito patrocinio si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura.
L’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, al primo comma, prevede che possa essere ammesso al beneficio “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito”, specificando poi, al comma 3, che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”: in conseguenza, nella dichiarazione vanno indicati i redditi rilevanti ai sensi dell’art. 76, come confermato dal tenore letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c).
Ciò posto, per la nozione di reddito, come testualmente prevede il citato art. 76, non può che farsi riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” ed in particolare agli artt. 1 e 6 dello stesso.
L’art. 1 (“Presupposto dell’imposta”), comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, pone il fondamentale principio secondo il quale “Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”, cui rinvia.
L’art. 6 “classificazione dei redditi” prevede, al comma 1, con elencazione “chiusa”, che “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi” e, al comma 2, che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
Nel caso di specie la somma percepita a seguito della morte di un figlio da parte dell’Inail è stata ritenuta non rientrante in alcuna delle categorie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 in quanto non si tratta di voce riconducibile ad alcuna delle categorie di redditi sopra indicate. Quanto alla categoria redditi diversi di cui alla lettera f) si tratta, come noto, di una categoria eterogenea, una variegata miscellanea priva di un presupposto specifico unitario, cui non può assimilarsi, in difetto di espressa indicazione da parte del legislatore, la rendita percepita dal padre quale indennizzo per la morte di un figlio da parte dell’Inail.
Il principio che si desume dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, confermato dalla giurisprudenza civile, anche con recenti pronunciamenti, è il seguente:
«In tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall’ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell’annullamento della delibera di esclusione dal concorso)» (Sez. 5, n. 10244 del 26/04/2017, A. vs. A., Rv. 643933-01);
«In tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera)» (Sez. 5, n. 29579 del 29/12/2011, Agenzia delle Entrate vs. Bernardi, Rv. 620975).
Il riferito principio, secondo il quale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione solo qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, non costituendo invece reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa, non è, peraltro, portato esclusivo della giurisprudenza civile.
Può, dunque, affermarsi che il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell’accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già nell’essere il reddito imponibile ovvero esente o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ma nella natura effettivamente reddituale o meno, nel senso che concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio ove esse siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito nella diversa ipotesi in cui tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura.
Cassazione penale, sez. IV, 15 settembre 2020, n. 27234