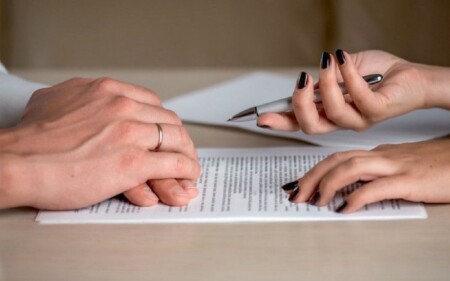Corte Costituzionale, 14 marzo 2014, n. 50
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle previsioni contenute nei commi 8 e 9 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (decreto sul federalismo fiscale che ha introdotto la cd cedolare secca). Le norme in questione introducevano delle “sanzioni” da applicare ai casi di affitti in nero. In particolare il comma 8 modificava di fatto gli accordi contrattualmente concordati tra le parti. Ed infatti, era previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che, ricorrendone i presupposti, non erano registrati entro il termine stabilito dalla legge:
- che la durata fosse stabilita in 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio,
- che il contratto fosse rinnovabile di altri 4, salvo deroghe previste per legge (disciplina dell’art. 2, c. 1, Legge n. 431/98).
- che, dalla registrazione, il canone annuo di locazione fosse pari al triplo della rendita catastale, oltre all’adeguamento, dal secondo anno, del 75% dell’indice Istat foi, salvo che il contratto prevedesse un canone inferiore.
Il comma 9 poi disponeva che la nullità del contratto di locazione non registrato, così come prevista dall’art. 1, comma 346 della legge n. 311/2004, si applicasse sia quando nel documento registrato era stato indicato un importo inferiore a quello effettivo e sia quando era stato registrato un comodato fittizio.
Tale disciplina risulta in contrasto, anzitutto, con il parametro di cui all’art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega, in riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), nonché in relazione anche agli artt. 6, comma 2, e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
La Consulta ha rilevato la carenza di delega delle norme suddette rispetto alla legge delega 42/2009, volta a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’art. 119, comma 5, cost. Un ambito normativo rispetto al quale la denunciata disciplina in materia di locazioni risulta del tutto estranea.
La disciplina censurata, inoltre, non rispetta i principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla l. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto sono disattesi sia il principio secondo cui le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto, sia gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto (sentt. n. 80, 293 del 2010; 219 del 2013).
L’articolo 10 della legge 212/2000 stabilisce che “le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”. Tuttavia secondo le previsioni della norma oggetto di censura, anche solo il ritardo nella registrazione, avrebbe comportato addirittura una novazione del contratto stesso, quanto a canone e durata.
L’art. 6 dello Statuto del contribuente prevede infatti che l’amministrazione finanziaria informi «il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione». Ne deriva che “la sostituzione contrattuale dell’amministrazione”, operando in via automatica, violava anche le previsioni dell’art. 6 dello Statuto, in quanto non rispettava gli obblighi di informazione del contribuente.
Viene dunque meno quella che negli intenti avrebbe potuto essere un’ottima arma contro gli affitti in nero giacché l’inquilino avrebbe avuto grande convenienza nel “denunciare” il locatore, registrando di propria iniziativa il contratto di locazione ottenendone l’automatica conversione in una regolare locazione di quattro anni + quattro a canone ultra ridotto, pari al al triplo della rendita catastale dell’immobile.
Il medesimo rimedio era previsto anche per il caso di contratti registrati indicando un importo inferiore a quello realmente sborsato o di comodato gratuito fittizio.
Art. 3 commi 8 e 9 d.lgs. 23/2011
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Corte Costituzionale, 14 marzo 2014, n. 50