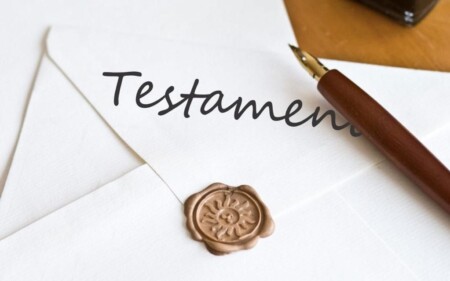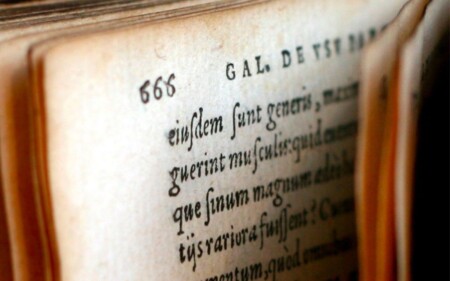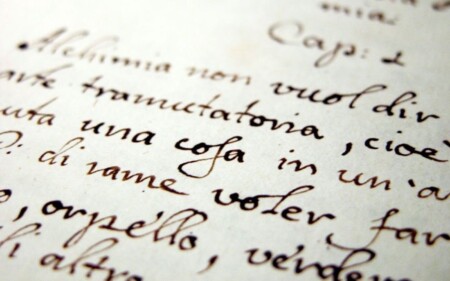Le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), come disciplinate dal ddl Calabrò, approdato questa settimana in aula al senato, non convincono i giuristi riuniti a Roma in occasione del IV Congresso di aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio nazionale forense. Il timore manifestato nel corso della sessione tematica dedicata al testamento biologico, coordinata dal consigliere nazionaleAntonio De Giorgi, è che le disposizioni previste dal disegno di legge comportino il sacrificio del diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione. Non si sarebbe un collegamento formale e sostanziale, in altre parole, tra il momento della cosiddetta alleanza terapeutica tra medico e paziente, quando quest’ultimo ha piene facoltà di intendere e volere che esprime attraverso il consenso informato, e quello critico delle scelte mediche effettuare in assenza di uno stato di intendere e volere del paziente.
Due gli aspetti problematici: la forma che deve assumere la manifestazione di volontà del paziente e la vincolatività per il medico delle Dichiarazioni anticipate di trattamento.
In maniera molto critica si è espresso Luigi Balestra, ordinario di diritto privato Bologna per il quale “la norma sul divieto di interruzione di idratazione e alimentazione mette in forse la stessa ragione del biotestamento, anche nel confronto con le discipline adottate negli altri paesi europei. E in più generale, sono tante le disposizioni del ddl che collidono con il principio di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente tutelato (articolo 13, IV comma)”.
Carlo Venditti, ordinario di diritto civile a Napoli, si è soffermato proprio sul principio di autodeterminazione del paziente che risulterebbe nel testo “fortemente limitato e circoscritto” nelle norme che prevedono la forma scritta e la data certa delle Dat, sulla enunciazione della loro vincolatività alla quale si contrappone la libertà del medico di seguirle o meno.
“Due sono le concezioni alternative sulle Dat: una concezione negoziale che ha come conseguenza la revocabilità del consenso nelle stessa forma e che implica la facoltà del medico di non attenersi; e una seconda, meno formalistica, che non esclude manifestazioni di volontà non qualificate e che implica una revocabilità assoluta del consenso, per la quale personalmente propendo”.
Per Vettori, vi è la possibilità di contemperare il principio di autodeterminazione del paziente e la funzione di garanzia del medico, che “potrà valutare, oltre ai tempi e i modi, anche se perpetrare certe terapie alla luce della conoscenza scientifica maturata al momento delle scelte terapeutiche”.
Alberto Maria Gambino, ordinario di diritto privato all’Università europea di Roma, si è soffermato sulle previsioni relative al rifiuto di cure, raffrontando la disciplina attuale, anche mutuata dalla giurisprudenza, con le previsioni del ddl Calabrò.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense