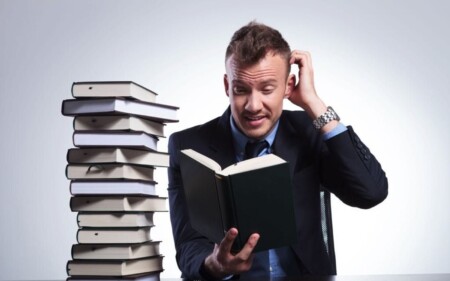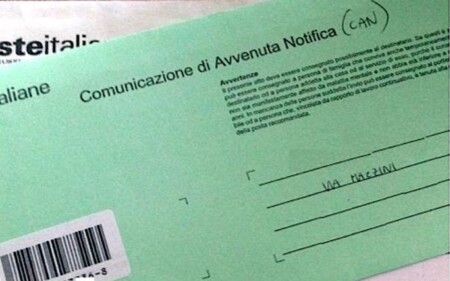Cassazione penale, sez. unite, 29 gennaio 2016, n. 15453
«In caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 104 disp. att. c.p.p.».
La Corte rileva innanzitutto come siano completamente diverse le finalità del sequestro preventivo – che mira ad inibire la libera disponibilità di un bene – rispetto a quelle del sequestro probatorio – che è un mezzo di ricerca della prova.
L’art. 321 c.p.p., comma 1, prevede la possibilità di disporre la misura cautelare quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Tale norma è inserita nel Capo 2^ (Sequestro preventivo), Titolo 2^ (Misure cautelari reali) del Libro 4^, vale a dire nello stesso libro in cui sono disciplinate le misure cautelari personali.
La collocazione sistematica della norma è significativa della “unificazione” nella categoria delle misure cautelari, sia di quelle personali che di quelle reali.
Il legislatore ha, cioè, preso atto della rilevanza sociale ed economica di taluni interventi di cautela reale su beni materiali e su diritti costituzionalmente garantiti (proprietà, domicilio, libertà di iniziativa economica), non dissimili da quelli incidenti sulla libertà personale.
Ne è derivata una disciplina unificante che ha comportato che anche per le misure cautelari reali venissero previsti gli stessi caratteri fondamentali delle misure cautelari personali in tema di autorità competente ad emettere la misura, predeterminazione dei criteri di applicazione, garanzie dei soggetti destinatari.
La polizia giudiziaria, nell’intervenire di sua iniziativa, in caso di urgenza, pone, infatti, in essere una misura precautelare di carattere provvisorio per impedire che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati.
Da quanto esposto emerge, con evidenza, la diversità ontologica e la diversa finalità delle due misure (sequestro probatorio e sequestro preventivo).
Mentre gli atti richiamati nell’art. 356 c.p.p., mirano, invero, ad assicurare le fonti di prova, il sequestro preventivo ha funzioni meramente cautelari.
Può, quindi, affermarsi che il legislatore abbia previsto la presenza (eventuale) del difensore, attraverso il meccanismo di avvertimento all’indagato ex art. 114 disp. att., soltanto in relazione agli atti richiamati dall’art. 356 c.p.p., in considerazione della vocazione probatoria di tali atti. Di qui la necessità del presidio difensivo a controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria.
Siffatta esigenza non è ravvisabile, invece, in relazione al sequestro preventivo, anche se eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di misura cautelare a carattere provvisorio destinata ad impedire la libera disponibilità di un bene.
Peraltro, non è ricavabile dal codice di rito un principio che consenta di ritenere sussistenti per le misure cautelari (stante la loro natura) meccanismi che prevedano necessariamente l’intervento “preventivo” della difesa.
A meno che il legislatore non abbia eccezionalmente (ma, in tal caso, indicandolo espressamente) previsto una sorta di contraddittorio anticipato, come nel caso della misura interdittiva di cui all’art. 289 c.p.c., comma 2.
Per il sequestro preventivo operato di iniziativa della polizia giudiziaria, il legislatore non solo non ha dettato alcuna disposizione in ordine alla possibilità del presidio difensivo fin dal momento dell’esecuzione (ad es. richiamando le previsioni dell’art. 356 c.p.p., e art. 114 disp. att.), ma ha piuttosto equiparato l’atto al fermo di indiziato di delitto di cui all’art. 384 c.p.p., che non prevede certo una garanzia difensiva “preventiva”.
L’art. 386 c.p.p., stabilisce, infatti, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria subito dopo il fermo diano immediata notizia al pubblico ministero ed avvertano il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Infine, ancora più marcate sono le differenze in relazione ai meccanismi di controllo (successivo) sull’attività posta in essere dalla polizia giudiziaria.
Per gli atti richiamati dall’art. 356 c.p.p., è prevista la trasmissione, entro quarantotto ore, del verbale al pubblico ministero, il quale nelle successive quarantotto ore convalida la perquisizione (art. 352 c.p.p., comma 4) o il sequestro (art. 355 c.p.p., comma 2).
Per il sequestro preventivo, invece, l’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, stabilisce che il verbale debba essere, entro quarantotto ore, trasmesso al pubblico ministero, il quale, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve entro le successive quarantotto ore richiedere al giudice la convalida. Inoltre il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (comma 3 ter).
Dalla lettura delle due norme emerge, con chiarezza, come soltanto per il sequestro preventivo (a differenza di quello probatorio) sia previsto un controllo immediato da parte del giudice (organo terzo) sull’operato della polizia giudiziaria.
Tale controllo in tempi brevi giustifica, ulteriormente, la mancanza del presidio difensivo al momento della esecuzione della misura.
Dalla mancata previsione di tale presenza (peraltro, come si è visto, soltanto eventuale per il sequestro probatorio) non deriva, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa.
Le garanzie difensive vengono, infatti, tutelate attraverso meccanismi di controllo da parte del giudice, che può, con celerità, ritenere non conforme a legge l’operato della polizia giudiziaria, evitando la convalida e disponendo la restituzione di quanto sequestrato.
Il sequestro preventivo d’urgenza si caratterizza, conseguentemente, come una misura precautelare a carattere provvisorio destinata a caducarsi se non venga convalidata dal giudice nei tempi strettissimi in precedenza evidenziati.
Tale meccanismo risulta conforme a Costituzione, venendo rispettate, in proposito, le stesse garanzie previste in tema di libertà personale e di inviolabilità del domicilio (art. 13 Cost., comma 3, e art. 14 Cost., comma 2).
Gli interventi in casi eccezionali di necessità ed urgenza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza hanno, invero, copertura costituzionale, purché siano indicati tassativamente dalla legge e siano convalidati dall’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore (altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto).
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“In caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 104 disp. att. c.p.p.”.
Art. 321 Cod. Pen. Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Cassazione penale, sez. unite, 29 gennaio 2016, n. 15453