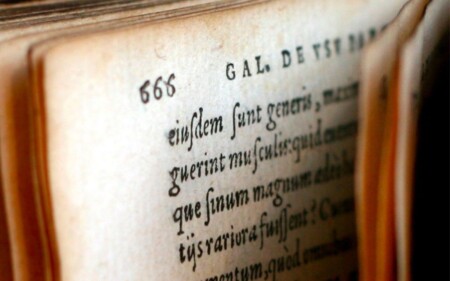Cassazione penale, sez. unite, 12 settembre 2012, n. 34952
Il delitto tentato è una fattispecie disciplinata dall’art.56 cod. pen. il quale prevede la punibilità a titolo di tentativo per chi compie atti idonei ed univocamente diretti alla realizzazione di un delitto ma l’azione non si compie o l’evento non si verifica per circostanze estranee ed indipendenti dalla volontà dell’agente. Il legislatore segna già al primo comma un importante limite all’ambito di operatività dell’istituto de quo: è ammesso in relazione ai soli delitti, mentre è incompatibile giuridicamente con le contravvenzioni.
La figura del tentativo è configurabile ogni qual volta sia ipotizzabile un iter criminoso che esordisce con l’ideazione del reato e culmina nella consumazione dello stesso, infatti il tentativo si colloca nella fase intermedia tra la perfezione del reato e la sua consumazione: la perfezione segna il limite della configurabilità del tentativo in quanto presuppone la realizzazione degli elementi minimi necessari e sufficienti descritti dalla norma incriminatrice, mentre la consumazione si configura quando il fatto di reato, già perfetto, raggiunge la sua massima gravità non essendo più ipotizzabile il tentativo. Pertanto, parte della dottrina, esclude la figura del tentativo per i reati unisussistenti che si estrinsecano in un solo atto e quindi si caratterizzano per l’assenza di un procedimento articolato attraverso cui si snoda la commissione del reato.
In dottrina e in giurisprudenza a lungo si è dibattuto circa l’autonomia della fattispecie de quo, in quanto alcuni studiosi avevano prospettato una interdipendenza con la parallela fattispecie consumata: la giurisprudenza propende, ormai da tempo, per l’autonomia del tentativo che trae la propria fonte dallo stesso art.56 cod. pen. in funzione estensiva, il quale accostato alle singole norme incriminatrici di parte speciale, previste in forma consumata, crea l’equivalente delitto in forma tentata. L’art. 56 cod. pen. è quindi denominato, per tale funzione estensiva, clausola moltiplicativa della fattispecie, come ad esempio l’art.110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato. in quanto autonomo il delitto tentato si compone di una base oggettiva e soggettiva, al pari del reato consumato.
Il fondamento della punibilità del tentativo, secondo la prevalente teoria oggettiva, è ravvisabile nella scelta del legislatore di anticipare la soglia di punibilità sanzionando quelle situazioni in cui il proposito criminoso si traduce in un comportamento materiale che espone il bene protetto al pericolo. Mentre per l’opposta teoria soggettiva si pone al centro dell’attenzione l’intenzione di delinquere manifestata dal reo già al principio di esecuzione della condotta incriminata: tale indirizzo contravviene al principio cardine del nostro diritto penale del fatto quale è cogitationis poena nemo patitur ancorando la rilevanza penale del tentativo ad elementi quali la personalità del reo e la sua pericolosità sociale. La ratio punitiva, invece, sta appunto nel tutelare la mera esposizione al pericolo, come avviene ad esempio nei reati di pericolo in cui si prescinde dall’effettivo nocumento al bene giuridico protetto secondo una tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore. Proprio per tale ratio il tentativo è stato ritenuto, da autorevole dottrina, incompatibile giuridicamente con i reati di pericolo perché si risolverebbe i una punibilità del pericolo di un pericolo e quindi di una mera probabilità, con effettiva compromissione del principio di materialità ed offensività che alberga nel nostro ordinamento a legalità formale-sostanziale. Proprio sulla base di tali argomentazioni il nostro codice penale, nell’individuare l’area penalmente rilevante del tentativo, ha introdotto due filtri oggettivizzanti a cui la condotta perseguibile deve parametrarsi: l’univocità e l’idoneità degli atti. Quando gli atti sono equivoci saremo fuori dall’area del penalmente rilevante e parimenti quando il tentativo sarà inidoneo, perché gli atti sono non idonei a realizzare il fatto, saremo in presenza di un reato impossibile non punibile ex art.49, 2comma.
Come anticipato il delitto tentato, nella sua struttura, si compone di elementi oggettivi attinenti alla condotta ed elementi soggettivi, al pari del reato consumato: la base oggettiva poggia, appunto, sull’univocità ed idoneità degli atti e sulla mancata realizzazione dell’azione o verificazione dell’evento; la base soggettiva invece attiene al solo criterio di imputazione del dolo, in quanto si esclude ontologicamente il delitto tentato colposo e il delitto tentato preterintenzionale.
Quanto all’univocità va premesso che in passato si sono fronteggiate due opposte teorie: da un lato la teoria soggettiva secondo cui sono univoci gli atti quando risulta certa, anche con prova aliunde, l’intenzione dell’agente di delinquere e quindi l’univocità sarebbe indice sintomatico di una volontà di commettere una fattispecie di reato consumata, avrebbe pertanto funzione probatoria ; dall’altro lato, la tesi oggettiva, prevalente, secondo cui l’univocità è requisito obiettivo della condotta, non desumibile aliunde e non sintomatico di una volontà di delinquere. La giurisprudenza moderna non distingue più gli atti preparatori, prima esclusi in toto dal tentativo punibile, e gli atti esecutivi-tipici cioè descritti dalla norma incriminatrice, come invece auspicava la giurisprudenza costituzionale e parte esigua della giurisprudenza di legittimità. Oggi la punibilità ex art.56 cod. pen. è estesa anche a quegli atti che seppur non tipici e non rappresentano un principio di esecuzione, sono nel complesso astrattamente diretti verso il fine criminoso per le circostanze di fatto esistenti in concreto: sono univoci quindi anche gli atti, qualificabili come preparatori, antecedenti a quelli esecutivi-tipici, ma ad essi funzionali e connessi cronologicamente. Si desume che si accoglie un’interpretazione estensiva della nozione di atto univoco.
Quanto all’idoneità degli atti ci si chiede se il segmento di condotta posto in essere sia in grado o meno di recare offesa al bene giuridico protetto. Si tratta di un giudizio prognostico ex ante su base parziale in quanto il giudice lo compie successivamente all’esecuzione della condotta ma riportandosi nel momento storico in cui la stessa è stata compiuta tenendo conto delle circostanze conosciute e conoscibili effettivamente dal reo e non tutte le circostanze esistenti pur se non conosciute. Il giudizio su base parziale ha quindi il pregio di dare rilevanza penale a quelle situazioni che sulla base di un giudizio su base totale andrebbero a priori escluse con netta riduzione della punibilità del tentativo in quanto il giudizio di idoneità si risolverebbe, nella maggioranza dei casi, con esito negativo, pertanto tale giudizio di prognosi postuma accoglie le istanze di general-prevenzione. Esso è inoltre fatto in concreto valutando i fatti e i segmenti della condotta posti in essere, illo tempore, hic et nunc. Quanto al grado di idoneità è sufficiente che la stessa sia più vicina alla probabilità che non alla mera non impossibilità.
Relativamente al mancato compimento dell’azione e al non verificarsi dell’evento, l’art.56 cod. pen. equipara le due ipotesi, rispettivamente di tentativo incompiuto e tentativo compiuto, distinti dal codice Zanardelli sotto il profilo sanzionatorio, oltre che strutturale., in quanto il tentativo non compiuto che si ha quando l’azione non si compie per cause non imputabili all’agente non era punibile.
In relazione all’elemento psicologico del reato, da accertare secondo i principi generali in materia di dolo ex art.42 cod. pen., va chiarito che la fattispecie tentata è configurabile nelle sole ipotesi di delitto doloso. L’incompatibilità ontologica con la fattispecie colposa si giustifica nella direzione finalistica degli atti richiesta dall’art.56 cod. pen.: nel delitto colposo l’evento pur se preveduto è non voluto e si realizza per imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di regole cautelari, mentre l’art.56 chiede che la condotta sia causalmente orientata verso la realizzazione di un fine criminoso.
Per lo stesso ragionamento si esclude il delitto preterintenzionale nella forma tentata in cui l’elemento soggettivo richiesto è il dolo misto a colpa, unitariamente intesi. Invero la compatibilità con il dolo non va intesa tout court, perché una serie di ritrosie in giurisprudenza si sono manifestate in ordine al dolo eventuale per il quale si esclude appunto la compatibilità con il tentativo, contraddistinto per la direzione finalistica dell’azione.
Ammesso pacificamente per il dolo intenzionale e il dolo diretto, anche sub specie del dolo alternativo, il tentativo si esclude nel caso di dolo eventuale, perché in questo l’agente si rappresenta come probabile o possibile il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso e malgrado ciò ne accetta il rischio. Ciò che caratterizza questa tipologia di dolo è appunto un diverso atteggiarsi dell’elemento volitivo rispetto al dolo diretto in quanto nel primo caso c’è una minore volontà adesiva, che mal si concilia con la direzione finalistica della condotta ex art. 56 cod. pen., mentre nel secondo c’è un alto grado di adesione all’evento, in quanto l’agente si rappresenta come altamente probabile la realizzazione di un evento dannoso o pericoloso e lo vuole.
La peculiarità morfologica del delitto tentato, come visto, deve coincidere con i requisiti delle singole fattispecie di reato previsti nel nostro ordinamento, compatibilità spesso messa in discussione dalla stessa giurisprudenza di legittimità in ordine a determinate categorie di reati. Abbiamo già avuto modo di evidenziare le criticità che derivano dall’accostamento del tentativo ai reati di pericolo, ai reati colposi, ai reati unisussistenti o ancora ai reati preterintenzionali.
Al vaglio della Suprema Corte è stata posta la questione relativa alla configurabilità del tentativo nel caso dei reati complessi, nello specifico nell’ipotesi del reato di rapina impropria.
Il reato complesso è categoria generale prevista dall’art.84 cod. pen. e si caratterizza per il fatto che elementi costitutivi o circostanze aggravanti dello stesso sono reati ex se, pertanto si compone di due o più fattispecie di reato. la ratio fondante della previsione di cui all’art.84 cod. pen. è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo per evitare il rischio di una doppia incriminazione. Quanto al tentativo, secondo una parte della dottrina, non sarebbe ipotizzabile per il reato complesso a meno che non sia tentata la seconda porzione della condotta che compone il reato complesso (cioè quella riferibile alla seconda fattispecie di reato) oppure sia indifferente l’ordine logico-temporale con si susseguono le diverse condotte che integrano le ipotesi delittuose. La giurisprudenza, al contrario, tende ad ammettere il tentativo di reato complesso e di recente ha consolidato il proprio indirizzo favorevole in relazione al reato di rapina impropria ex art. 628, 2 comma cod. pen..
Il reato di rapina è reato complesso composto dal reato di furto e o violenza privata o altro delitto a base violenta fino alle percosse. La rapina è propria, comma 1 art.628 cod. pen., quando l’uso della violenza o della minaccia è strumentale all’impossessamento del bene altrui, sono quindi il mezzo attraverso cui si realizza la fattispecie di furto. È impropria, comma 2, quando ls violenza o la minaccia sono perpetrate in un momento immediatamente successivo rispetto alla sottrazione del bene e vengono attuate per assicurarsi il possesso della cosa sottratta oppure per procurare a sé o a terzi l’impunità.
Il problema dell’ammissibilità del tentativo nasce dalla particolare struttura della rapina impropria : se la sottrazione del bene avviene e resta allo stadio del tentativo la condotta violenta, nulla quaestio, avremo tentativo di rapina impropria; se la sottrazione non avviene ma si compie la violenza per ottenere l’impunità ci si chiede se c’è concorso di reati tra tentativo di furto ex art.624 cod. pen. e violenza privata consumata ex art.610 (o altro delitto a base violenta) con scomposizione del reato complesso nelle singole fattispecie che compongono il reato de quo.
La dottrina maggioritaria fautrice della tesi negazionista ha addotto a sostegno della incompatibilità del tentativo con il reato di rapina impropria una serie di argomentazioni. In primis seguendo la lettera della norma è chiaro, per tale tesi, che la violenza e la minaccia sono successive alla sottrazione ,la quale oltre ad essere prius logico-temporale della condotta violenta, deve essere portata a consumazione affinché possa concretizzarsi, appunto, l’aggressione violenta. Ne consegue che in caso di mancata sottrazione non si potrà avere il reato di rapina impropria nella forma tentata, ma al più un tentativo di furto in concorso con la fattispecie delittuosa a base violenta.
Altro argomento a sostegno è l’inquadramento dogmatico della condotta di sottrazione intesa quale presupposto logico-temporale del reato di rapina impropria e quindi estraneo all’elemento oggettivo; da tale impostazione derivano due ordini di conseguenze: da un lato non sarà configurabile il tentativo in quanto presupposto esterno alla struttura del reato, dall’altro il venir meno di esso non consente di trattare il reato de quo come unitario (perché complesso) e quindi non giustificherebbe l’inasprimento sanzionatorio quale ratio punitiva dell’art.628, 2 comma.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite, ha affermato nuovamente il proprio orientamento favorevole, invero già consolidato, smontando le singole argomentazioni asserite dalla tesi opposta, tacciata di essere estremamente formalista e poco attenta alle esigenze sostanziali sottese all’art.628 cod. pen..
Quanto all’argomento letterale, la Corte, partendo proprio dalla lettera della norma, ha evidenziato che il legislatore pone come finalità della violenza, alternativa all’impossessamento, il procurarsi l’impunità: pertanto la sottrazione non è da intendersi come segmento necessario e antecedente rispetto all’uso della minaccia o della violenza. Ne consegue che in caso di mancata sottrazione il reato de quo andrà inteso come un’unica fattispecie tentata e non sarà ammesso il tentativo di furto in concorso col la violenza.
Inoltre la Corte di Cassazione rigetta la tesi opposta nella parte in cui inquadra la condotta di sottrazione come prius logico-temporale rispetto alla condotta violenta in quanto tale impostazione trascura l’esigenza di cogliere l’unitarietà del reato complesso che giustifica, appunto, l’inasprimento del trattamento sanzionatorio. L’ammissibilità del tentativo trova il proprio fondamento, a detta della giurisprudenza di legittimità, proprio nella ratio punitiva del reato di rapina impropria: il legislatore, nelle sue scelte di politica criminale, ha voluto colpire maggiormente l’aggressione violenta al bene-patrimonio e al bene-persona, seppur nella forma tentata, perché la ragione sottesa alla fattispecie complessa è quella di sanzionare più rigidamente le forme di aggressione a base violenta di uno o più beni giuridici. Scomporre la fattispecie in caso di tentativo di sottrazione eluderebbe le scelte di politica criminale del legislatore con compromissione della ratio punitiva della norma stessa.
In ultima battura la Suprema Corte rileva come non vi siano elementi sufficienti per superare il proprio orientamento favorevole, in quanto alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem è stato perpetrato, come invece ha sostenuto la dottrina negazionista la quale ha asserito che ammettere il tentativo nel reato di rapina impropria significherebbe estendere le maglie della norma oltre il dictum del legislatore, con grave compromissione del principio di legalità sub specie del divieto di analogia in malam partem. La Corte di Cassazione ha sottolineato l’aderenza della propria impostazione favorevole al principio di legalità, in ossequio ai principi enunciati dall’art.7 CEDU di prevedibilità ed accessibilità della norma incriminatrice, il cui significato diviene di portata generale per il consociato, grazie anche all’intervento chiarificatore della giurisprudenza nel rispetto del principio di stretta interpretazione.
Cassazione penale, sez. unite, 12 settembre 2012, n. 34952