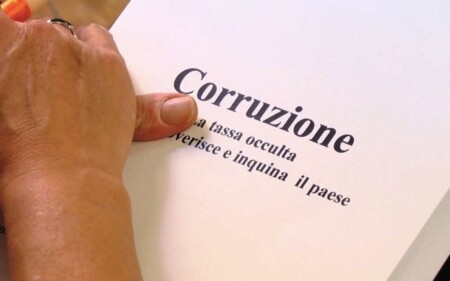Si stima che il 7,9% delle famiglie italiane nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi di corruzione. Tra le famiglie che hanno acconsentito a pagare, l’85,2% ritiene che sia stato utile per ottenere quanto desiderato.
- Per la prima volta l’Istat ha introdotto una serie di quesiti nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015- 2016 per studiare il fenomeno della corruzione.
- Si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi).
- L’indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione.
- La corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività lavorativa (2,7%).
- Tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, si stima che il 2,9% abbia avuto nel corso della propria vita una richiesta di denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri.
- Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori.
- In ambito sanitario episodi di corruzione hanno coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi. Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1% dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori
- Richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte di forze dell’ordine o forze armate e nel settore dell’istruzione hanno riguardato rispettivamente l’1% e lo 0,6% delle famiglie.
- La stima più bassa di corruzione riguarda le public utilities: sono soltanto 0,5% le famiglie che al momento di richiedere allacci, volture o riparazioni per energia elettrica, gas, acqua o telefono hanno avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti.
- Nella maggior parte dei casi di corruzione degli ultimi 3 anni c’è stata una richiesta esplicita da parte dell’attore interessato (38,4%) o questi lo ha fatto capire (32,2% dei casi); appare meno frequente la richiesta da parte di un intermediario (13,3%).
- La contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%).
- Tra le famiglie che hanno acconsentito a pagare, l’85,2% ritiene che sia stato utile per ottenere quanto desiderato.
- Sempre con riferimento alla corruzione, inoltre, il 13,1% dei cittadini conosce direttamente qualcuno fra parenti, amici, colleghi o vicini a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori ed ammonta al 25,4% la popolazione che conosce persone che sono state raccomandate per ottenere privilegi.
- Tra i casi non formalmente classificabili come corruzione si stima che al 9,7% delle famiglie (più di 2 milioni 100mila) sia stato chiesto di effettuare una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati.
- Il 3,7% dei residenti fra 18 e 80 anni (oltre 1 milione 700mila) ha ricevuto offerte di denaro, favori o regali in cambio del voto alle elezioni amministrative, politiche o europee. Il 5,2% degli occupati, infine, ha assistito a scambi di favori o di denaro considerati illeciti o inopportuni nel proprio ambiente di lavoro.
Nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016, l’Istat ha introdotto un modulo volto a studiare il fenomeno della corruzione. Si tratta di un approfondimento che per la prima volta vuole offrire una stima del numero di famiglie coinvolte nel corso della propria vita in dinamiche corruttive: sono state intervistate 43mila persone tra i 18 e gli 80 anni di età a cui è stato chiesto se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni nell’accesso a un servizio o di un’agevolazione. L’attenzione è quindi rivolta alle esperienze concrete: è stato anche chiesto se vi sia stato uno scambio, in quale modo sia avvenuto, la sua entità e il suo esito, il comportamento di denuncia. Al contempo è stata anche rilevata la conoscenza indiretta di casi di corruzione, cioè se si è venuti a conoscenza, nel proprio ambiente, di persone – come amici, colleghi e familiari – che abbiano ricevuto richieste di denaro, favori o regali in cambio di servizi.
Da ultimo, è sembrato importante rilevare il voto di scambio e le raccomandazioni, che possono essere considerati fenomeni che favoriscono la dinamica corruttiva. Nella progettazione dell’indagine sono stati definiti otto settori chiave in cui esplorare tutte queste componenti: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell’ordine, public utilities.
Su questi primi risultati si fonderanno ulteriori sviluppi inerenti alla tematica della corruzione, così come stabilito dal protocollo d’intesa con Anac1 in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione.
Coinvolte 1 milione 742mila famiglie
Si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi).L’indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione.
La corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività lavorativa (2,7%).
Tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, si stima che il 2,9% abbia avuto nel corso della propria vita una richiesta di denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri.
Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori. In ambito sanitario episodi di corruzione hanno coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi. Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1% dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori
Richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte di forze dell’ordine o forze armate e nel settore dell’istruzione hanno riguardato rispettivamente l’1% e lo 0,6% delle famiglie.
La stima più bassa di corruzione riguarda le public utilities: sono soltanto 0,5% le famiglie che al momento di richiedere allacci, volture o riparazioni per energia elettrica, gas, acqua o telefono hanno avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti.
Nella maggior parte dei casi di corruzione degli ultimi 3 anni c’è stata una richiesta esplicita da parte dell’attore interessato (38,4%) o questi lo ha fatto capire (32,2% dei casi); appare meno frequente la richiesta da parte di un intermediario (13,3%).
La contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%).
Tra le famiglie che hanno acconsentito a pagare, l’85,2% ritiene che sia stato utile per ottenere quanto desiderato.
Sempre con riferimento alla corruzione, inoltre, il 13,1% dei cittadini conosce direttamente qualcuno fra parenti, amici, colleghi o vicini a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori ed ammonta al 25,4% la popolazione che conosce persone che sono state raccomandate per ottenere privilegi.
Tra i casi non formalmente classificabili come corruzione si stima che al 9,7% delle famiglie (più di 2 milioni 100mila) sia stato chiesto di effettuare una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati.
Il 3,7% dei residenti fra 18 e 80 anni (oltre 1 milione 700mila) ha ricevuto offerte di denaro, favori o regali in cambio del voto alle elezioni amministrative, politiche o europee. Il 5,2% degli occupati, infine, ha assistito a scambi di favori o di denaro considerati illeciti o inopportuni nel proprio ambiente di lavoro.
Quanto al settore giustizia, sono il 2,9% le famiglie che hanno avuto una richiesta di denaro, regali o favori da parte di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri. In particolare per il 2,1% delle famiglie la richiesta si è esplicitata nell’ambito delle cause civili.
La richiesta di denaro o scambi ha coinvolto il 2,7% delle famiglie che nel corso della vita hanno fatto domanda di benefici assistenziali come contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità e il 2,1% delle famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici. In particolare si stima all’1,5% la percentuale delle famiglie a cui è accaduto quando si sono recate presso uffici pubblici comunali, della Regione o della Provincia.
Percentuali ancora inferiori si hanno per le richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte delle forze dell’ordine o delle forze armate (1%), nel settore dell’istruzione (0,6%), al momento dell’iscrizione a scuole universitarie o di specializzazione o per essere promosso, rispettivamente lo 0,2% e lo 0,5%.
La percentuale più bassa riguarda le public utilities: sono lo 0,5% le famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l’energia elettrica, il gas, l’acqua o il telefono, hanno avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti.
Le richieste di denaro si verificano più frequentemente nei settori lavoro, sanità e uffici pubblici nel complesso; tuttavia la graduatoria cambia per i casi registrati più di recente. Nei 12 mesi precedenti l’indagine, la sanità si colloca al primo posto, seguita da uffici pubblici, settore del lavoro e public utilities. Naturalmente la graduatoria risente anche della diversa frequenza con cui si ricorre ad alcuni servizi nelle diversi fasi del ciclo della vita.
Il 9,8% delle famiglie che ha ricevuto almeno una richiesta di denaro, favori o regali ha almeno un componente con titolo di studio elevato (contro il 7,3% delle famiglie senza componenti con titolo di studio elevato) (Prospetto 2).
La richiesta di denaro per l’attività lavorativa emerge con più frequenza nelle famiglie in cui vi sono liberi professionisti e imprenditori e aumenta all’aumentare della presenza di queste categorie di lavoratori nella famiglia.
Questi dati sono stati associati ad ulteriori informazioni. Alle persone che lavorano come liberi professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi è stato chiesto se hanno vissuto esperienze dirette di corruzione nella propria attività (ad esempio per ottenere o velocizzare licenze, permessi o concessioni, essere agevolati nei controlli fiscali, ottenere contratti con istituzioni pubbliche). Si stima che tali episodi si siano verificati nel 2,5% dei casi, più frequenti al Centro (5,7%) meno al Nord-ovest (0,8%).
La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata. L’indicatore complessivo di corruzione stimato varia tra il 17,9% del Lazio e il 2% della Provincia autonoma di Trento. Valori particolarmente elevati presentano anche l’Abruzzo e la Puglia, rispettivamente 11,5% e 11%, la Basilicata e il Molise, mentre all’opposto si collocano alcune regioni del Nord come la provincia autonoma di Bolzano, il Piemonte e la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.
La corruzione in sanità è più frequente in Abruzzo (4,7%) e in Campania (4,1%). A tale proposito la richiesta di effettuare una visita privata prima del trattamento nella struttura pubblica è elevata in Puglia (20,7%), Basilicata (18,5%), Sicilia (16,1%) e Lazio (14,4%). La richiesta di tangenti o favori in cambio di benefici assistenziali è invece sensibilmente superiore al dato medio nazionale (2,7%) in Molise (11,8%), Puglia (9,3%), Campania (8,8%) e Abruzzo (7,5%).
In ambito lavorativo i casi di corruzione sono più segnalati nel Lazio (7,4%) e in Puglia (6,3%), seguono Liguria (4,2%), Sardegna (4,2%) e Basilicata (4,1%). Nel Lazio (5,7%) e in Puglia (4,8%) è presente la percentuale più alta di famiglie che hanno avuto richieste di denaro quando si sono rivolte a uffici pubblici (Comune, Provincia, Regione, aziende sanitarie locali, vigili del fuoco, ecc.).
Le famiglie che vivono nei centri dell’area metropolitana hanno ricevuto una richiesta di denaro o favori in cambio di servizi in proporzione quasi doppia rispetto a chi vive nei comuni più piccoli fino a 10 mila abitanti (rispettivamente 11,3% e 6%); le percentuali sono elevate anche nei comuni delle periferie delle aree metropolitane (9,4%) (Prospetto 3). Tuttavia i settori riflettono la diversa esposizione ad eventi di possibile corruzione: in sanità sono maggiori nei comuni periferici alle aree metropolitane mentre nelle grandi città è più elevata la percentuale di famiglie che hanno avuto richieste di denaro o regali al momento della ricerca del lavoro.
Rispetto al quadro generale il panorama degli ultimi 3 anni è leggermente diverso. Il Sud detiene il primato di casi di corruzione, seguono il Centro e le Isole; tra le regioni emergono Abruzzo, Lazio e Puglia.
Negli ultimi 3 anni le famiglie che hanno avuto richieste di denaro o regali/favori in cambio di servizi è maggiore nei comuni delle periferie delle aree metropolitane con un sorpasso netto dei comuni centro delle aree stesse (4,1% le prime, 3,6% le secondo contro la media del 2,7%).
Gli attori della corruzione
In sanità la richiesta di denaro o altri beni è avvenuta da parte di un medico nel 69% dei casi (da un primario di medicina nel 20,2%), da un infermiere nel 10,9% o da altro personale sanitario nel 19,6% dei casi, mentre per un altro 11,1% si è trattato di figure professionali non sanitarie.
Anche per la corruzione nel settore assistenziale, nel 23,5% dei casi i protagonisti sono stati i medici e nel 22,1% i dipendenti degli enti locali (comune, provincia e regione) e altri dipendenti pubblici o del patronato. Nell’ambito dei contatti con le public utilities la corruzione si manifesta attraverso richieste di dipendenti delle aziende della distribuzione elettrica (44,6%) e del gas (31,3%).
A parte alcuni settori tipicamente legati alla dimensione della vita personale come la sanità, i benefici assistenziali, l’istruzione, gli altri settori riguardano potenzialmente sia la sfera personale che lavorativa. La corruzione nel settore degli uffici pubblici, ad esempio, nel 50% dei casi circa si è attivata quando si sono cercati servizi legati all’ambito lavorativo e degli affari, nelle public utilities la dimensione lavorativa arriva al 34% circa.
Il denaro è l’oggetto privilegiato dello scambio
L’oggetto di scambio più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), soprattutto per ciò che attiene i settori dell’assistenza (65,7%), dei contratti con le compagnie di elettricità, gas, acqua e telefoni (63,6%) e della sanità (61,2%); seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), che caratterizzano di più il comparto uffici pubblici (22,9%), e i regali (9,2%). In misura minore il contenuto dello scambio è una prestazione sessuale (4,6%) o altri favori (7,6%)
Lo scambio di denaro viene indicato in percentuale più alta dagli abitanti del Centro (72,2%), delle Isole (64%) e, soprattutto, da chi vive nei grandi comuni (83,1%); favori e trattamenti privilegiati sono stati richiesti di più nelle Isole (20,9%) e nei comuni fino a 10mila abitanti (23,2%).
Sono il 35,6% le famiglie che hanno accettato di corrispondere alla richiesta di denaro o di fare regali4: la percentuale è massima nel settore delle public utilities (54,6%), seguono gli uffici pubblici (37,4%), l’ambito sanitario (36,4%), quello dell’assistenza (24,2%) e il lavoro (18,2%). Elevate anche in questo caso le non risposte per i settori giustizia e forze dell’ordine.
In più di un caso su due (52,8%) l’ammontare versato non supera i 500 euro mentre per il 12,7% la cifra corrisposta è oltre tale soglia. Il 15,2% non ricorda e il 19,4% ha preferito non rispondere.
Se l’accordo contempla un regalo, nella maggior parte dei casi il suo valore non ha superato i 150 euro previsti dalla legge n.190 del novembre 20125, che stabilisce in tale somma il valore minimo consentito per non essere considerato un caso di corruzione.
Più di otto famiglie su dieci soddisfatte di quanto ottenuto
Tra le famiglie che hanno accettato lo scambio, l’85,2% ritiene che aver pagato sia stato utile per ottenere quanto desiderato: in particolare nell’ambito dei singoli settori, il rendimento è totale per le public utilities (99,1%) e particolarmente elevato per ottenere un lavoro (92,3%) o una prestazione sanitaria (82,8%).
Pur di ottenere un servizio il 51,4% delle famiglie ricorrerebbe di nuovo all’uso del denaro, dei favori o dei regali (73,8% nel caso di una prestazione sanitaria). Per contro, il 30,9% delle famiglie non lo rifarebbe: il 37,8% perché lo ritiene un comportamento scorretto che danneggia la collettività, mentre una quota analoga, ragionando in termini di utilità, non si reputa soddisfatta di quanto ottenuto. Il 25,2% riconosce di aver pagato per un servizio che gli sarebbe spettato di diritto.
In pochi denunciano
La quota di famiglie che hanno avuto richieste di corruzione denunciando l’episodio è solo del 2,2%, la quasi totalità non lo ha fatto (95,7%), il 3,3% preferisce non rispondere e l’1,9% non sa o non ricorda.
Tra i motivi della non denuncia viene evidenziata soprattutto la sua inutilità (39,4% dei casi) e la consuetudine della pratica per raggiungere i propri obiettivi (14%); seguono il non sapere chi denunciare (12,5%) e la paura delle rappresaglie e delle conseguenze, anche giuridiche, della denuncia (12,4%). Altri invece ribadiscono l’utilità del vantaggio avuto a seguito della transazione corruttiva (9,2%)
Altre motivazioni interessanti, ma residuali, della scelta di non denunciare sono la convinzione che l’aver dato denaro/regali è stato un segno di gratitudine (1,3%) e la consapevolezza che non essendoci prove o una richiesta esplicita, comunque le autorità non avrebbero potuto fare nulla (3,8%).
Non sporgere denuncia perché inutile e perché non interesserebbe a nessuno è la modalità più segnalata nei casi di corruzione per ottenere i benefici assistenziali; nel settore della sanità viene accentuato anche l’aspetto dell’utilità e della normalità della corruzione.
Il 13,1% degli intervistati conosce persone vittime di corruzione
Si stimano in oltre 6 milioni (13,1% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) i cittadini che dichiarano di conoscere personalmente qualcuno – parenti, amici, colleghi o vicini – a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori. La prevalenza varia a seconda del settore coinvolto: dal 7,1% per il settore del lavoro (con richieste di denaro o altri beni per essere assunti in un posto di lavoro o per avviare un’attività lavorativa) al 5,9% nel settore della sanità (per essere facilitati in occasione di ricoveri, interventi chirurgici o altre cure) al 4,0% per le facilitazioni di tipo assistenziale come pensioni, alloggi e altri contributi, (Prospetto 7).
Oltre che sulla base del settore coinvolto, le prevalenze variano anche in relazione all’area geografica di residenza: si passa dal 7,9% dei cittadini residenti nel Nord-est, (l’area meno coinvolta del Paese, con il minimo del 3,9% in Friuli Venezia Giulia) al 19,7% del Sud, con la Puglia che registra la prevalenza più alta, pari al 32,3% (Prospetto 7 e 8). Prevalenze decisamente più elevate rispetto alla media nazionale del 13,1% si rilevano anche nel Lazio (21,5%), in Abruzzo (17,5%), Sicilia (15,4%) e Sardegna (15,0%).
Quasi 2 milioni di persone hanno assistito a scambi illeciti sul lavoro
Agli occupati e a coloro che hanno lavorato in passato è stato chiesto se hanno mai assistito, nel loro ambiente di lavoro, a scambi di favori o di denaro che hanno considerato illeciti o inopportuni. È capitato a oltre 1 milione e 900 mila persone (5,0%)
Le regioni con i tassi stimati più elevati sono Lazio (7,5%), Veneto (7,2%), Liguria (6,9%), Sardegna (5,9%), Emilia Romagna (5,8%) e Lombardia (5,5%). I settori di attività economica in cui più di frequente si assiste a questi scambi sono quelli delle intermediazioni monetarie e finanziarie (13,6%), sanità e altri servizi sociali (8,8%) e costruzioni (7,4%).
Nel 55% dei casi, tuttavia, le persone che hanno assistito a questi scambi illeciti non hanno preso alcuna iniziativa, il 17,3% ne ha parlato soltanto con persone al di fuori dell’ambito lavorativo come familiari o amici, il 13,9% con colleghi fidati e il 9,4% direttamente con la persona coinvolta.
Solo l’11,8% lo ha segnalato a un superiore e appena l’1,9% al responsabile anticorruzione presente sul luogo di lavoro anche se, al riguardo, va segnalato che questa figura è prevista solo nell’ambito della Pubblica Amministrazione e da pochi anni a questa parte (Legge n° 190/2012).
Il voto di scambio ha interessato 1 milione 700 mila persone
Nel nostro Codice penale il voto di scambio è classificato fra i reati contro l’ordine pubblico con la denominazione di “scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416ter del Codice Penale). Pur con una diversa classificazione giuridica rispetto alla corruzione – che è un reato contro la P.A. – il voto di scambio ne condivide, per alcuni aspetti, la fenomenologia. In questo caso il pactum sceleris avviene fra un elettore e un politico, o un suo intermediario, che trasformano in oggetto di scambio quel voto che secondo la nostra Costituzione (art. 48) dovrebbe essere “eguale, libero e segreto”.
Si stima che ad oltre 1 milione 700mila cittadini (3,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) sono stati offerti denaro, favori o regali per avere il loro voto alle elezioni amministrative, politiche o europee (Prospetto 10). Il voto di scambio è più frequente in caso di elezioni amministrative e raggiunge i picchi più alti al Sud e nelle Isole, dove ne ha avuto qualche esperienza, rispettivamente, il 6,7% e l’8,4% della popolazione. Tutte le regioni del Sud, fatta eccezione per il Molise, presentano tassi sensibilmente più elevati rispetto alla media Italia, con il massimo del 9,7% in Basilicata.
In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati (34,7% dei casi), nomine o posti di lavoro (32,8%) o addirittura denaro (20,6%).
Sono, infatti, più del doppio (3 milioni 858 mila) gli italiani che dichiarano di conoscere personalmente qualcuno – parenti, amici, colleghi, vicini – a cui è stato offerto qualcosa in cambio del voto in qualche tornata elettorale. Si tratta dell’8,3% della popolazione di riferimento, con una particolare concentrazione del fenomeno, anche in questo caso, nel Sud del Paese e nelle Isole. Il picco più alto si registra in Puglia dove quasi un cittadino su quattro (23,7%) conosce qualcuno a cui è stato proposto il voto di scambio.
Il Friuli Venezia Giulia (1,1%), Bolzano (1,2%) e Trento (1,8%) sono, invece, le aree meno coinvolte del Paese. Sempre al di sotto della media nazionale si posizionano, inoltre, il Piemonte (3%), la Lombardia, la Liguria e l’Emilia Romagna (3,5%).
Il punto di vista di imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi
A imprenditori, lavoratori autonomi e lavoratori in proprio che a livello personale non hanno ricevuto alcuna richiesta di denaro, regali o altra utilità per ottenere servizi o facilitazioni in ambiti attinenti alla loro attività lavorativa, è stato chiesto quale fosse la loro percezione sulla corruzione. Il dato stimato è elevato: il 32,4% dichiara che nel settore in cui opera succede sempre o spesso di essere obbligati a pagare per ottenere licenze e concessioni o contratti con la P.A. o permessi per l’import e l’export, o per agevolare pratiche fiscali o velocizzare procedure giudiziarie. Un ulteriore 19% afferma che succede almeno qualche volta. Questa percezione è più diffusa nel caso si tratti della richiesta di licenze e concessioni Con riferimento, invece, ai diversi settori di attività economica, nella percezione degli imprenditori e dei lavoratori autonomi intervistati il settore delle costruzioni è quello più esposto (il 37% dichiara che si è costretti a pagare sempre o spesso nei diversi ambiti) seguito dall’industria in senso stretto (34,7%) e dai servizi (32,5%).
La raccomandazione, costume diffuso in molti aspetti della vita
Il sistema delle raccomandazioni è così ampio, in Italia e non solo, da essere spesso considerato una pratica quasi normale. In ambito lavorativo, nel nostro Paese il canale di intermediazione più utilizzato e anche il più efficace per la ricerca di lavoro è quello informale in ambito familiare e amicale: lo ha utilizzato circa il 60% degli attuali occupati e per oltre il 33% ha rappresentato anche il canale d’ingresso nell’attuale lavoro.
L’intermediazione di familiari o amici non sempre o non necessariamente si traduce in una raccomandazione. Tuttavia la sua rilevante diffusione rischia di tagliare fuori dal mercato del lavoro coloro che non hanno adeguati network relazionali o sociali.
L’uso di intermediazioni, di segnalazioni o di vere e proprie raccomandazioni non si limita alla ricerca di lavoro ma coinvolge o può coinvolgere diversi ambiti in cui i cittadini avvertono la necessità di aggirare gli ostacoli, o più semplicemente, cercano scorciatoie ad esempio per ottenere l’accesso a prestigiose scuole o università, a corsi di dottorato o di specializzazione, per farsi assegnare alloggi o benefici assistenziali, per farsi cancellare multe o altre sanzioni.
Si stima che quasi 12 milioni di italiani (25,4% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) conosce personalmente qualcuno che è stato raccomandato: per ottenere un posto di lavoro (21,5%), una licenza, un permesso o una concessione (7,5%), per farsi cancellare multe o sanzioni (7,5%), per benefici assistenziali (6,8%), per l’ammissione o la promozione a scuole e università (4,9%) o per essere favorito in cause giudiziarie (1,9%).
Le conoscenze personali e le raccomandazioni risultano quindi particolarmente diffuse in relazione alla ricerca del lavoro e, con riferimento al territorio, in maniera più marcata in Puglia (34,3%), Basilicata (31,8%), Sardegna (30,5%), Lazio (29,9%), Umbria (26,3%) e Abruzzo (25,7%). In questo ambito, si registrano, inoltre, percentuali più elevate rispetto al dato nazionale anche nei comuni centro dell’area metropolitana (23,5%) e nei comuni con più di 50.000 abitanti (23,6%).
Puglia (41,8%), Basilicata (36,2%), Lazio (33,7%) e Sardegna (36,6%) sono, inoltre, le regioni in cui la prevalenza di persone che conoscono raccomandati in uno o più settori è particolarmente alta e molto più elevata della media nazionale (25,4%).
L’8,3% degli italiani (10,5% degli uomini e 6,1% delle donne) ha ricevuto personalmente la richiesta di raccomandazioni, favori o di fare da intermediario con altri. Le richieste di raccomandazioni sono rivolte soprattutto agli uomini della fascia d’età 55-59 anni (16,2%), alle persone con titolo di studio universitario (15,7%) e in posizione lavorativa di dirigente (28,4%) o quadro (19,7%).
Questo malcostume appare più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,3%) e al Nord- est (10,8%), in particolare in Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Veneto, e nei comuni centro dell’area metropolitana (9,2%)
Articolo tratto da: ISTAT Istituto nazionale di statistica